L’amico dei “matti”
«Che il diavolo non esiste l’ho capito stando tra i matti..». Lo psichiatra Vittorino Andreoli nell’intervista rilasciata a Candida Morvillo, Corsera del 13-4-23, si sofferma su episodi della sua esperienza motivando le sue convinzioni che possono essere di grande aiuto per comprendere la crisi attuale della psichiatria, delle tragedie umane in tante Residenze Socio-sanitarie, per la vita e la convivenza umana. Andreoli ricorda «..bruciai tutte le cinghie per i malati, nessuno mi ha mai fatto del male.. Sentivano che io a loro volevo bene. Se stabilisci una relazione, non hai bisogno di legare un malato. Poi, per controllare le pulsioni, servono i farmaci. Ma tuttora, l’80 per cento dei malati viene legato: la psichiatria è in grave crisi perché bisogna essere prima umani e poi psichiatri»
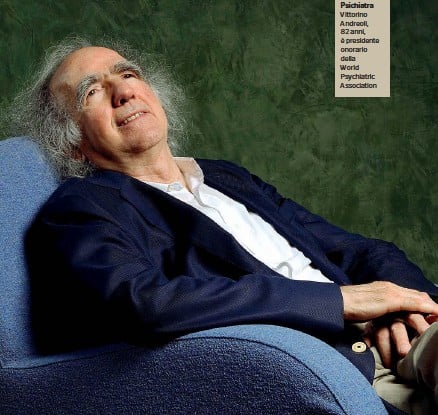
Professor Vittorino Andreoli, lei sostiene che tutti possiamo avere un momento in cui potremmo uccidere. Lei questo momento l’ha avuto?
«Ho avuto l’istinto di ammazzare un collega psichiatra, uno che contava, e che molestava una dottoressa che lavorava per lui e mi aveva chiesto aiuto: era angosciata perché lui la toccava, la convocava solo per molestarla. E lei era terrorizzata: non voleva concedersi, ma aveva paura di perdere il lavoro. Mentre lo raccontava, ho sentito la pulsione omicida perché lo psichiatra dovrebbe invece aiutare le persone».
Lei è celebre anche per non aver mai legato un malato in 50 anni di mestiere: come ha fatto? E perché i suoi colleghi ancora oggi li legano?
«Quando trentenne, nel ‘71, divenni primario dell’Ospedale Psichiatrico di Marzana, a Verona, dissi a medici e infermieri di non legare più i malati gravi, ma che se avessero avuto bisogno, io sarei arrivato in cinque minuti. Contavo sul fatto di conoscere bene la farmacologia dopo le esperienze all’Istituto Farmacologico di Milano e in America. La mattina dopo, la caposala mi aspettava agitatissima, dice: venga, venga, un malato sta rompendo tutto, è pericoloso. Salgo, sento un rumore terribile in una stanza: urla, oggetti spaccati, bam bam. Fuori, tutti gli infermieri e i medici di turno. Dico alla caposala: apra la porta. Lei rimane ferma con la chiave in mano. L’infermiere più anziano mi fa: prof, conosco suo padre, la prego, non lo faccia».
La racconta come una scena da gladiatore col leone.
«Entro e vedo tutto divelto, il lavabo per terra, spaccato. Al che, inizio a rompere tutto quello che non era ancora rotto. Prendo il lavello o e bam bam, lo sbatto e risbatto per terra. Il malato si calma. Mi guarda. Io continuo. Lo ammetto: rompere mi dava una soddisfazione incredibile. Alla fine, prendo il malato sottobraccio, lo porto nel mio ufficio, gli dico di non rompere mai più niente fino al mio arrivo alle otto del mattino e lui così fece. Dopo, feci raccogliere i mezzi di contenzione e appiccai un falò in giardino. Sentii un piacere quasi fisico. Da allora, mai un malato mi ha dato uno spintone».
La percepivano come un fratello di follia?
«Sentivano che io a loro volevo bene. Se stabilisci una relazione, non hai bisogno di legare un malato. I miei collaboratori non l’hanno più fatto e nessuno ha più rotto niente. Poi, per controllare le pulsioni, servono i farmaci. Ma tuttora, l’80 per cento dei malati viene legato: la psichiatria è in grave crisi perché bisogna essere prima umani e poi psichiatri».
Lei racconta sempre che ha studiato da geometra per accontentare suo padre, ma che già allora voleva diventare «medico dei matti». Come nasce questa sua passione?
«Papà aveva iniziato come muratore ed era diventato cavaliere delle Repubblica. Ci teneva che continuassi la sua azienda edile, ma io studiavo di nascosto latino, greco, matematica perché, per l’università, serviva il liceo. E ora posso dire che, senza le tragedie greche, non saprei fare lo psichiatra. Comunque, dopo il diploma, gli dissi: papà, non me la sento, voglio occuparmi dei matti. Mi guardò, ma non disse niente. È stato il mio eroe. Feci l’ultimo anno di liceo ed eccomi qua».
Non mi ha detto come arriva la passione per «i matti».
«Perché frequentavo l’Azione Cattolica e alcuni miei compagni erano ossessionati dal demonio. Tutti ricevevamo un’educazione terrificante: il peccato era in agguato, il diavolo pure. Il mio amico Guido veniva a parlarmi di Satana, ne era spaventato. Io dicevo: non c’è. E lui: c’è, è qui. Non sapevo come aiutarlo. E mi venne la curiosità di visitare il vicino manicomio di San Giacomo Della Tomba».
Suppongo che le piacque.
«Mi colpirono soprattutto le donne buttate per terra, prive di ogni dignità, fascino. Il direttore mi disse: avrà cambiato idea. Risposi: no, queste persone hanno bisogno di tutto, perciò, forse, qualcosa di buono per loro posso farlo. Il direttore mi permise di tornare nei fine settimana per occuparmi dell’atelier di pittura dove i pazienti potevano esprimersi dipingendo e che poi ho seguito per tutta l’università. Ogni domenica, mamma sperava che portassi a casa una ragazza, ma io portavo un pittore matto».
Si laureò a Padova, lavorò a Cambridge, al Cornell Medical College di New York, quindi il neuroscienziato Seymour S. Kety le offrì una cattedra ad Harvard. Perché non accettò?
«Perché mia moglie, incinta della seconda figlia, mi disse: sono contenta, te lo meriti, però io e le bambine torniamo in Italia. Non le piaceva l’educazione empirica e superficiale che avrebbero ricevuto lì. Aveva ragione, ce lo diciamo ancora. E in Italia scelsi di fare clinica, nell’ex manicomio frequentato da studente».
Stare insieme da 60 anni è indice di amore folle o è da matti?
«È da persone che hanno capito che le modalità esistenziali cambiano, come l’amore nella vecchiaia. L’errore è un modello d’amore che vale solo a 40 anni».
Sulla vecchiaia, ha scritto per Solferino, «A una certa età». Com’è la sua certa età?
«Mi piace tanto lamentarmi. Dire: nessuno pensa a me. Ho tre figlie, cinque nipoti ed è stupendo perché la decodifica è: ho bisogno di voi, non mi sento amato. La vita va vissuta come un gioco».
La felicità è possibile?
«È un termine che odio perché riguarda l’io: prediligo la gioia perché riguarda il noi».
Possiamo dire che è lei che ha trovato le tre ragioni della follia?
«Quando ho iniziato, c’erano la scuola deterministica Lombrosiana, in cui tutto era legato a un’alterazione del cervello, e quella “democratica” di Franco Basaglia che faceva dipendere tutto dalla società. Io, usando un metodo da scienziato, ho trovato una terza via, oggi prevalente: il comportamento dell’uomo, sano o disturbato, è sempre il risultato di tre fattori, ovvero: biologia, esperienze e ambiente fisico e relazionale. La premessa è che, essendo il cervello plastico, si può intervenire per curare e anche questa premessa è una scoperta oggi accettata da tutti».
I social hanno cambiato il funzionamento del cervello?
«Certo. È impossibile che uno che vive per ore della logica meccanica di Internet sappia usare la logica della mente, dei sentimenti. Ma il mondo è in mano a imbecilli da diagnosi psichiatrica».
Faccia nomi e diagnosi.
«Per non prendere querele, dico solo che uno che vuole portarci nello spazio o ibridarci col robot è un pazzo totale e incapace di affettività: un Asperger. E un altro, quello che crea mondi alternativi, è un oligofrenico: significa che ha poco cervello».
Fra baby gang e omicidi per futili motivi, vede un aumento dei disturbi psichiatrici?
«La risposta è sì. Il malato mentale è uno che ha trovato un modo per vivere in una situazione in cui le frustrazioni superano le gratificazioni, cosa frequente in questo mondo dominato dal denaro, dove dilagano violenza e stupidità».
Un antidoto c’è?
«L’unico sarebbe l’amore».

Pur non essendo espeta del settore, condivido pienamente quanto espresso dal Prof Andreoli.
Ho avuto esperienze con persone affette da demenza senile, e avendone la possibilità, ho vietato l’uso dei mezzi di contenimento. Mi sono creata dei nemici tra il personale, che non sempre condivideva ( e magari boicottava) ma questo è ovvio.
Comunque la soddisfazione più grande che ho avuto dai “malati” è stata la loro fiducia.
Sorridevo e li guardavo negli occhi con affetto, chiedevo che facessero altre cose da quello che volevano fare e spiegavo il perchè, mi ascoltavano quasi sempre.
Non cìè nulla di più gratificante ed emozionantee che sentirsi dire: di lei mi fido!